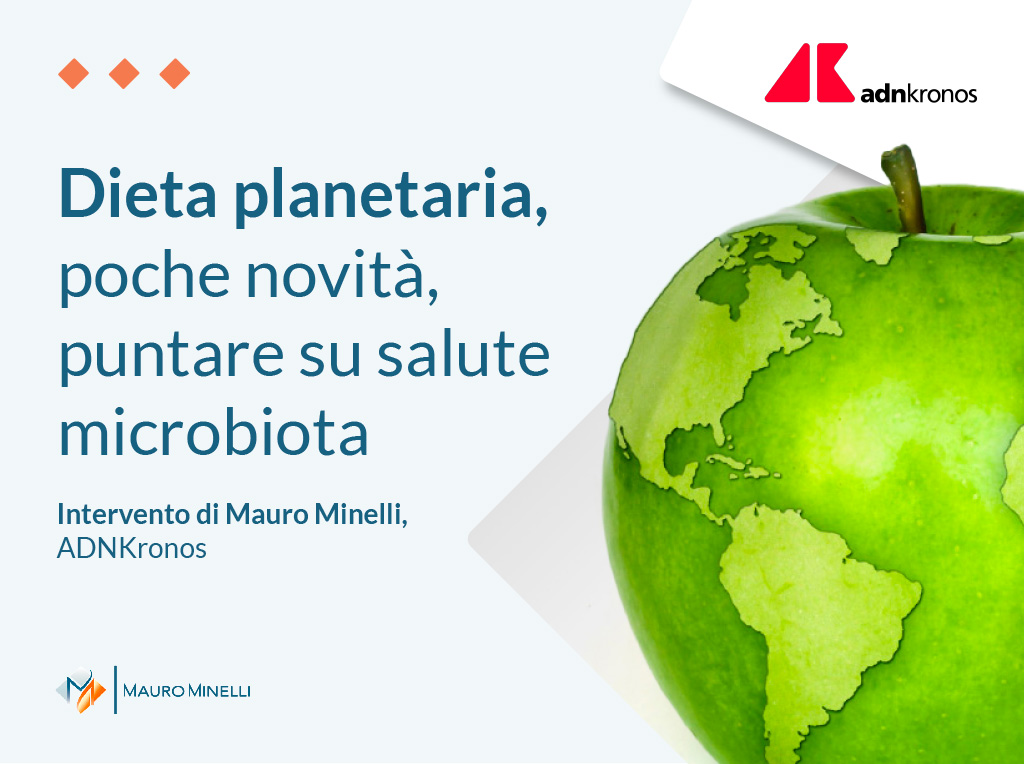
07 Ott Cosa è la Dieta Planetaria? È davvero la rivoluzionaria soluzione per un’alimentazione sana?
La Commissione Eat-Lancet 2025 ha presentato quella che viene definita, ad oggi, l’analisi scientifica più completa dei sistemi alimentari globali. Nel documento si spiega che “soluzioni sostenibili ed eque sono a portata di mano” e che la ‘Planetary Health Diet’ (Phd), che privilegia alimenti vegetali poco trasformati con un consumo moderato di prodotti animali come carne e latticini, è associata ad un rischio di mortalità prematura inferiore del 27%.
Mauro Minelli, immunologo clinico e docente di Nutrizione Umana alla Lum, approfondisce l’analisi su Adnkronos.
Se è vero che una dieta, intesa come modello alimentare abituale, non può essere solo tradizione, è altrettanto vero che essa va comunque considerata come un sistema relazionale che lega le pratiche alimentari quotidiane ad un territorio e alla sua biodiversità. La dieta planetaria, concepita come regime alimentare volto a ridurre il consumo eccessivo di carne rossa e zuccheri e ad aumentare l’apporto di cereali integrali, legumi, frutta, verdura, semi e noci, sostanzialmente prevede una significativa riduzione dei prodotti di origine animale. Per questo, essa risulta affine a quel modello alimentare che, già diversi anni fa, fu riconosciuto da ricercatori americani stabilitisi in Italia come di grande valore medico e salutistico.
Ma se questo metodo, codificato negli anni 60 da Ancel Keys (1904–2004), richiama una regola di vita legata ad un territorio che si affaccia sul Mar Mediterraneo e alla storia delle sue genti, una dieta “planetaria”, che meritoriamente ripropone scelte alimentari sostanzialmente simili a quelle in origine maturate nell’area cilentana, dove si colloca precisamente? A quale contesto geografico si lega? Da quale territorio trae le sue risorse? E a quale utenza si rivolge? A quale sapienza, intesa come cultura e tradizione del cibo, si richiama?
Era nel bacino del Mediterraneo che l’alimentazione tradizionale prevedeva un’abbondante ingestione di verdura e frutta, legumi e cereali, il tutto condito con olio di oliva, usato in quest’area da sempre. I latticini avevano un ruolo importante, come pure il pesce, mentre le carni erano consumate più raramente e soprattutto in occasioni festive. È possibile, oggi, esportare queste scelte tal quali in altre contrade? È davvero possibile riproporre ad ogni latitudine le abitudini alimentari del bacino mediterraneo come antidoto contro gli inconvenienti causati dalla classica dieta americana: iperproteica, iperlipidica, ipercalorica, sovrabbondante di carboidrati raffinati e carente, invece. di molte sostanze importanti per la salute?
Ma c’è di più!
Se è a tutti noto che i grassi saturi son legati ad infiammazione e insulino-resistenza, mentre i grassi polinsaturi hanno effetti benefici tanto più se associati ad un corretto equilibrio tra proteine e carboidrati, può non essere altrettanto nota la correlazione tra dieta e attività modulatoria di un sistema ipercomplesso, composto da migliaia di miliardi di microrganismi organizzati in una comunità fortemente eterogenea e vivace, chiamata microbiota intestinale.
Quel che oggi si sa è che questa smisurato ecosistema viene profondamente influenzato dai diversi macronutrienti, con conseguente produzione di svariati metaboliti essenziali per la salute dell’ospite, e che, pure in condizioni eubiotiche, esistono delle differenze interindividuali che caratterizzano la microflora di ciascuno. Come dire, in altri termini, che la diversità, la composizione e la funzione metabolica del microbiota intestinale sono strettamente associate ai nutrienti assunti con l’alimentazione e al modello dietetico adottato. Sicché, fattori della dieta come quelli ad azione pre- e pro-biotica e, più in generale, i “modelli dietetici” influenzano fortemente la composizione qualitativa e quantitativa del microbiota intestinale, contrastando o favorendo lo sviluppo e la progressione di numerose malattie intestinali ed extra-intestinali.
Dunque, alla luce delle evidenze scientifiche emerse sul ruolo del microbiota intestinale nella regolazione del metabolismo e nella prevenzione di patologie cronico-degenerative, si rende necessaria una nuova visione strategica che orienti le politiche pubbliche verso modelli alimentari certamente più salutari e sostenibili ma anche personalizzati, promuovendo al contempo percorsi di sviluppo integrati tra salute, nutrizione, educazione e innovazione agroalimentare.
La rivoluzione culturale della nutrizione personalizzata
La vera innovazione delle politiche nutrizionali pubbliche, più che nell’individuazione generica di un piano di riferimento globale, sta nel riconoscere in quest’ultimo un impatto complessivamente positivo sulla salute umana e sul carico delle malattie non trasmissibili. Ciò implica la necessità di incentivare, oltre che il consumo di fibre e alimenti prebiotici attraverso linee-guida dietetiche aggiornate che poggino su criteri di adattabilità individuale, anche campagne educative e interventi normativi su etichettatura e riformulazione dei prodotti. L’inserimento di criteri microbiota-oriented nei programmi scolastici, ospedalieri e aziendali rappresenta una leva concreta per modificare i comportamenti alimentari su larga scala. L’innovazione nel campo della nutrizione personalizzata, con particolare riferimento allo sviluppo di alimenti funzionali ad alto valore microbiotico, rappresenta una delle frontiere più promettenti della medicina preventiva e della salute pubblica.
Solo traducendo le indicazioni generali della Planetary Health Diet in un piano definito se non per ogni singolo individuo, almeno per individui appartenenti a specifici contesti geografici nei quali le diete sono dipendenti dalla prevalenza di alcuni alimenti rispetto ad altri, potrà essere possibile trarre reali benefici da questo modello nutrizionale.
Oltre ad una solida validazione scientifica, tuttavia, tali innovazioni richiedono nuovi modelli regolatori e una sinergia tra ricerca pubblica, industria e sistemi sanitari. È fondamentale, inoltre, favorire l’accessibilità equa a queste tecnologie, affinché la medicina di precisione non diventi un privilegio, ma uno strumento di salute collettiva. In prospettiva, un approccio integrato che combini profilazione del microbiota, analisi nutrizionale e intelligenza artificiale potrà rivoluzionare la prevenzione primaria, spostando l’asse della medicina dal trattamento alla predizione e alla personalizzazione, con effetti realmente positivi sulla qualità della vita delle persone ad ogni latitudine, e sulla sostenibilità dei sistemi sanitari.




